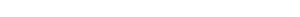Fare ricerca è parte integrante del fare design, meglio ancora se con un respiro internazionale. È questo il principio che guida Alessandro Biamonti, architetto, docente, coordinatore del Laboratorio di Innovazione e Ricerca sugli Interni (Lab.I.R.Int).
Il discorso si fa ancora più interessante quando ad essere toccate sono tematiche sensibili e complesse. Da diversi anni il professor Biamonti si occupa di terapie non farmacologiche per il trattamento della sindrome di Alzheimer e per questo gli abbiamo chiesto di raccontarci il suo percorso di lavoro.
Lo abbiamo incontrato durante le riprese de “L’acqua non muore mai”, un documentario diretto da Barbara Roganti che parla dell’Alzheimer partendo dal racconto di persone, relazioni ed esperienze positive. Parte dei filmati è girata presso Piazza Grace al quartiere Figino, primo Villaggio Alzheimer della città di Milano.
Professore, come si è accesa la lampadina del fare ricerca e progetto su questo tema?
Dall’incontro con Ivo Cilesi, noto terapeuta e innovatore nell’ambito in questione, da poco scomparso. In quel momento stavo conducendo, assieme a dei colleghi, un’esplorazione del design di interni visto da un punto di vista antropologico, quindi vicino alla dimensione sensoriale e percettiva. Si indagava la relazione mamma-bambino, quando Cilesi mi coinvolse su un tema completamente diverso, quello degli anziani affetti da demenza.
La molla del nostro incontro era una convinzione comune, ovvero che le terapie farmacologiche possono essere supportate da ciò che chiamiamo progetto. Va ricordato che Cilesi stava introducendo in Italia questo tipo di approccio, al tempo poco diffuso ma per entrambi di grande interesse.
Il design, in questo caso, diventa un modo per mettere al centro il paziente e il suo benessere. Ci vuole illustrare il vostro metodo?
Quando dico “progetto” mi riferisco a un ampio insieme di pratiche: intervenire sugli spazi, ma anche immaginare dispositivi e, talvolta, servizi che operano intorno alle persone con Alzheimer.
Da tempo cerchiamo di fornire quelli che chiamiamo habitat terapeutici, in cui si tengono insieme diverse componenti: estetica ed ergonomica – la cui importanza, sul fronte Alzheimer, non va mai sottovalutata – e soprattutto un’attenzione primaria alla qualità della vita delle persone. Per il nostro team, gli habitat sono stati un’importante tappa di un percorso partito dal design di interni, dove a un certo punto la dimensione strettamente fisica ha ceduto il passo ad elementi intangibili o soft qualities, legati alla sfera percettiva e sensoriale. Ci è stato molto utile mutuare il concetto di “habitat” dalla biologia, dove esso non corrisponde tanto a uno spazio quanto a un set di condizioni come umidità, temperatura, colori, suoni, ecc.
Dal dialogo con il personale sociosanitario è emersa la rilevanza terapeutica di questi aspetti contestuali, partendo dal dato oggettivo che ciascuno di noi in alcuni posti sta bene e in altri male, ovvero che le condizioni ambientali possono indurre una sensazione di benessere, o al contrario provocare ansia, nervosismo o tristezza. Si tratta di meccanismi in parte culturali o legati all’esperienza, in parte antropologici, che nel caso degli anziani con Alzheimer possono avere un impatto fondamentale sulla risposta alle terapie.

Un “habitat” è anche una realtà dinamica, suscettibile a input esterni, spesso imprevedibile e quindi difficile da immaginare come esito di un progetto. In cosa si traduce, di fatto, la componente legata al design?
Nel creare delle possibilità. Si tratta di un tema su cui lavoriamo ormai da anni, nell’attività di ricerca come nei laboratori didattici, assieme agli studenti. I nostri progetti non sono mai completamente finiti, bensì qualcosa che diventa strumento nelle mani di qualcun altro – nel nostro caso i terapeuti – e che mantiene un suo grado di adattabilità e tolleranza a modifiche anche non previste, visto che ogni utente reagisce in modo diverso. Le soluzioni fisse non funzionano, in questo ambito.
Ci può fare degli esempi?
Un caso classico è la doll therapy. Si tratta di un approccio piuttosto dibattuto, in cui al paziente viene fornita una bambola antropomorfa che di solito ha uno straordinario potere calmante, ma che non può dirsi universalmente efficace. Ivo Cilesi mi faceva notare che, nel caso di pazienti con determinati traumi alle spalle (come la perdita di un figlio piccolo), può anche indurre malumore e frustrazione.
I nostri habitat cercano di porre rimedio a questi rischi puntando su una maggiore flessibilità, attraverso lo sviluppo di un set di stimoli configurabili in una molteplicità di ambienti virtuali (la cabina di un treno, un bosco o altro), a seconda della sensibilità del paziente.
Perché questi habitat aumentano l’efficacia dei trattamenti non farmacologici?
Perché questi ultimi si focalizzano sull’azione come mezzo per diminuire o eliminare il carico farmacologico, e gli habitat solitamente consentono al paziente di distendersi senza l’uso di calmanti. È il caso, ad esempio, della terapia del treno e dell’apposita cabina da noi progettata, un dispositivo che simula un viaggio in scompartimento con i suoi vari aspetti (il paesaggio che scorre, la conversazione, ecc.). Si tratta di un’esperienza comune più o meno a tutti, che generalmente distende e ha un effetto lievemente ipnotico.

Quanto è importante il confronto con i terapeuti, nel vostro lavoro?
È centrale, perché lo spunto iniziale di solito parte da loro. Lavorando ogni giorno a contatto con i pazienti e i loro bisogni, i terapeuti hanno intuizioni talvolta decisive, ma hanno bisogno di supporto per tradurle in soluzioni e risposte adatte, al cui sviluppo possiamo provvedere noi come designer, architetti e tecnici. È un lavoro di squadra fondato soprattutto su un reale ascolto reciproco. Questo tipo di collaborazione funziona molto bene e costituisce un valido sostegno alle terapie, la cui efficacia risulta potenziata.
Si tratta dunque di dare vita alle loro idee?
Non solo. Il nostro compito in alcuni casi è semplicemente di svilupparle, in altri di introdurre elementi nuovi come determinate tecnologie, poco note o sconosciute al personale clinico. Quindi anche noi progettisti portiamo la nostra visione, talvolta incontrando delle divergenze con i terapeuti.
La proposta di avviare sperimentazioni in ambiente simulato, ad esempio, all’inizio ha suscitato forti perplessità, sulla base della convinzione che la dimensione virtuale-digitale non sarebbe stata percepita dai pazienti. Tale opinione è stata poi smentita dai fatti, essendo apparsa subito chiara una partecipazione più che attiva degli anziani coinvolti.
Abbiamo quindi proposto delle innovazioni che alla fine sono state molto apprezzate, tant’è che ora abbiamo due progetti in corso che fanno leva sugli ambienti virtuali. In generale, i momenti di disaccordo non sono un male e aiutano a comprendere meglio e perfezionare l’azione.
Voi progettisti avete delle interazioni dirette con le persone affette da Alzheimer?
I nostri contatti con loro avvengono sempre in presenza dei terapeuti e nell’ultimo biennio si sono ridotti al minimo, date le misure di protezione applicate ai centri diurni a fronte della pandemia. Ad ogni modo sì, un’interazione tra progettisti e pazienti avviene, e anzi è fondamentale per testare l’efficacia delle soluzioni che immaginiamo.
Non bisogna pensare che il design e la ricerca siano due aspetti separati, tantomeno in questo ambito dove, oltre a dover prevedere reazioni non ordinarie da parte dei pazienti, è necessario osservarle attentamente in tutta la loro casistica e costruirne un campionario, che serve poi a dare una giusta direzione al progetto.
Che cosa possono insegnare le persone con Alzheimer a chi fa design?
Loro – e anche i terapeuti – ci insegnano anzitutto l’importanza di mantenere la massima apertura mentale, quale presupposto di buona riuscita di un progetto. Il mondo-Alzheimer è fatto di persone con caratteristiche fuori dall’ordinario o, come da tempo diciamo, “extra-ordinarie”, che impongono al designer di non attenersi più a parametri di “normalità” o “standard”, di cui peraltro si riconoscono i limiti anche in ambiti di progettazione più convenzionali. Ciò rende il lavoro più impegnativo, per certi aspetti, ma sicuramente più avvincente, venendo rimessa in gioco la cultura stessa del progetto.
Un’altra osservazione che vorrei fare, di carattere più generale e valida da un punto di vista umano, è che confrontandosi con queste persone e facendo esperienza dei loro spazi di vita ci si rende conto che la malattia di Alzheimer è una condizione con cui si può convivere. Credo si tratti di un messaggio importante per chiunque.

Tra gli output della vostra ricerca si contano molte tesi di laurea. Come valuta il contributo dei collaboratori più giovani, lontani – per età ed esperienza – dalle questioni legate alla senilità?
Si tende a pensare che i giovani siano poco sensibili al problema, ma non è così. Al tempo del primo workshop, una decina di anni fa, sapendo che la classe era composta da studenti sui vent’anni pensai: «Sono giovani, si sono iscritti a Design per progettare discoteche e negozi, ora che dico loro su cosa lavoreremo chissà cosa mi tirano addosso!». Invece mi sbagliavo completamente. Nel giro di tre giorni assimilarono il tema a fondo, cogliendone gli aspetti essenziali, e mostrarono di saper rispondere con idee sensate e mature.
Con piacere posso dire di averne conferma ogni volta, visto che il corso è tuttora in programma. Quest’anno abbiamo 60 iscritti, 10 in più rispetto all’anno scorso. I ragazzi vengono regolarmente a chiedermi se vi siano sbocchi nel sociale e come poter lavorare da designer in questo particolare ambito, una volta laureati.
Da dove proviene questo interesse?
Ci sono almeno due elementi da considerare.
Il primo è che, a causa dell’allungamento dell’aspettativa di vita e di alcune determinanti sociali, le demenze sono sempre più diffuse nelle famiglie. Quindi un ventenne di oggi tende ad avere più familiarità con questo tipo di condizione, rispetto a quanto avveniva in un passato anche non lontano. Basti pensare che più della metà dei circa cinquanta studenti del mio corso ha un parente o una persona prossima con sindrome di Alzheimer.
Il secondo aspetto è, a mio avviso, generazionale: si tratta di ragazzi in gamba, che si interessano al prossimo e si dedicano con serietà a quello che fanno, e non – come alcuni pensano – di sfaticati che vivono su internet. Anche gli operatori sanitari rimangono spesso impressionati nel vedere i loro esercizi, ad esempio i video che faccio creare loro a inizio corso, per rompere il ghiaccio.

In ultimo, sappiamo che l’Alzheimer e le senilità sono ancora oggetto di stigma sociale. In che modo un prodotto di comunicazione può aiutare il pubblico a capire meglio queste persone e la loro sensibilità?
Informando e facendo vedere non solo il lato negativo della malattia. Anche se è doveroso ricordare che si tratta di una sindrome, con tutte le sue criticità, credo sia comunque doveroso raccontare il tema nella sua pienezza.
C’è infatti un altro lato della storia: che la vita di queste persone non è “perduta” e, anzi, può conservare una qualità che non esito a definire buona. Ciò è possibile a patto che noialtri riusciamo a superare un’ottica rigidamente razionale e ad accogliere, fin dove possibile, il loro punto di vista sulle cose, che talvolta è sorprendente.
Un esempio?
Il titolo del documentario che si sta girando in questi mesi: “L’acqua non muore mai”. È una frase detta da un paziente con Alzheimer, che a noi non verrebbe mai in mente. A causa della loro patologia, queste persone sviluppano una percezione distaccata della realtà ed esprimono uno sguardo eccentrico sulle cose che, per certi aspetti, presenta delle analogie con quello degli artisti. Del resto, anche Picasso demoliva la prospettiva e da molti era giudicato folle; eppure la sua arte ha rivoluzionato il Novecento.