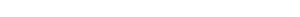Una delle grandi sfide dell’ultimo ventennio per lo studio e la conservazione dei beni culturali è lo sviluppo di tecniche di indagine non invasive, ossia tecniche e dispositivi capaci di raccontarci e svelarci lo stato di conservazione di un’opera, così come la tecnica e i materiali usati dall’artista, senza al contempo rovinarla. Le opere d’arte sono infatti oggetti unici ma allo stesso tempo estremamente delicati, che ci tramandano la storia dell’arte e dell’umanità stessa nel corso dei secoli. A questo scopo ci viene incontro la fotonica, una branca dell’ottica e della fisica, che negli ultimi decenni ha permesso lo sviluppo di dispositivi ottici e spettroscopici sempre più precisi, portabili e ridotti in dimensioni, in grado di darci informazioni molteplici sulla natura dei materiali che compongono un’opera d’arte.
Per aiutarci a capire tecniche così complesse, abbiamo chiesto a Daniela Comelli, docente del Politecnico e responsabile del gruppo di ricerca ArtIS (Imaging and Spectroscopy for Art) del Dipartimento di Fisica.

L’attività di ricerca di questo laboratorio si focalizza sullo sviluppo di metodi di spettroscopia e di imaging per lo studio non-invasivo di opere d’arte. Tra le tecniche utilizzate hanno particolare rilievo l’imaging di fluorescenza risolta in tempo, l’imaging iperspettrale e la spettroscopia Raman. Non spaventatevi, sono tutti termini che chiariremo fra poco.
Tra le straordinarie opere su cui ha lavorato questo gruppo troviamo uno dei pugnali ritrovati nel sarcofago di Re Tutankhamon, un manoscritto illuminato della collezione della Biblioteca Trivulziana di Milano, due tra le più famose sculture in marmo di Michelangelo – il David e la Pietà Rondanini – e i dipinti di arte moderna “Les bretonnes et le pardon de pont Aven” di Van Gogh e “Femme (Époque des ‘Demoiselles d’Avignon’)” di Pablo Picasso.
Come è nata la sua passione per la fisica applicata al mondo dell’arte?
Ho iniziato la mia tesi in un ambito applicativo molto diverso, quello della biologia e della medicina, dove utilizzavo le stesse tecniche di spettroscopia per immagini che oggi impiego per studiare le opere d’arte. Allora – si parta di vent’anni fa circa – analizzavamo dei topolini su cui erano stati inoculati dei tumori per studiare l’efficacia di alcune terapie anti-tumorali. Nell’ultimo anno di dottorato mi sono spostata nel mondo dell’arte, e mi è piaciuto tanto che ho deciso di rimanere.
Quali sono le difficoltà quando si ha a che fare con opere d’arte?
La complessità delle opere d’arte dal punto vista materico: quello che ho imparato a capire infatti è che quando si analizza un’opera d’arte si ha a che fare con la presenza di svariati materiali, spesso tra loro sovrapposti e a volte degradati rispetto ai materiali originali usati dall’artista. In conseguenza di questa complessità quando si studia un’opera d’arte diventa quindi essenziale usare un approccio “multi-analitico”, ossia impiegare diverse tecniche di indagine, tra loro complementari, per poter capire che cosa c’è dietro un’opera d’arte. Alcune richiedono il prelievo di campioni, e possono essere in alcuni casi invasive o distruttive.
Come si fa a renderle meno invasive?
Adesso c’è un forte interesse sullo sviluppo di tecniche non invasive, cioè che possano essere utilizzate senza arrecare alcun danno all’opera, e che siano realizzabili tramite strumenti portatili. Raramente infatti un’opera viene da noi, siamo in genere noi che ci spostiamo per analizzarla. Le domande che ci vengono poste dai conservatori e curatori dell’opera sono tante: qual è la tecnica utilizzata dall’artista, quali sono i materiali utilizzati e se vi sono dei processi di degrado in corso.
Iniziamo il nostro viaggio dal pugnale ritrovato nel sarcofago di Tutankhamon…
Il primo posto che esploriamo è l’antico Egitto. Abbiamo avuto la possibilità di studiare uno dei due pugnali ritrovati nel sarcofago di re Tutankhamon, vissuto tra il 1341 e il 1323 a.C. È stata una ricerca lunga e complessa, ma è sicuramente uno degli studi più affascinanti che abbiamo realizzato nel contesto egittologico.
Siamo nel quattordicesimo secolo a.C., nel periodo di Amarna, e oltre a quella dell’antico Egitto, avevamo altre importanti civiltà come l’impero ittita, i Mitanni, gli Assiri. Il nonno di Tutankhamon era Amenofi III, faraone che lasciò un Egitto molto florido e pacifico, grazie a un trattato con la vicina popolazione dei Mitanni. Il suo successore, Amenofi IV, portò dei grossi cambiamenti, soprattutto religiosi, perché decise di sostituire il dio Amon e gli altri dei con un’unica divinità, creando una sorta di monoteismo del dio Aton, rappresentato dal sole. Amenofi IV e la moglie si ritenevano addirittura emanazione diretta di Aton, tanto che il re cambiò nome in Akhenaton, ovvero “colui che agisce per conto di Aton”, e spostò la capitale religiosa da Tebe alla nuova città di Akhetaton, presso l’attuale Amarna.
Suo figlio Tutankhaton ascese al trono ancora bambino, ma presto cambio nome in Tutankhamon, “immagine vivente di Amon”, perché con lui si tornò alla religione politeistica con Amon e gli altri dei, cancellando quello che aveva fatto suo padre, organizzando addirittura una campagna per ripristinare i culti e demolire i templi dedicati ad Aton. Sicuramente fu un faraone molto amato, che morì però molto giovane, a soli 19 anni.

Credit: © The Egyptian Museum of Cairo
Il ritrovamento della sua tomba, all’epoca fu un evento…
Le ricerche furono condotte dall’archeologo Howard Carter e durarono dal 1915 al 1922. Era una tomba grandiosa, che conteneva al suo interno più oro di quello che c’era in quel periodo nelle banche egiziane.
Ci vollero tre anni prima che si aprisse il sarcofago. Carter trovò alcuni oggetti preziosi nella mummia: erano i doni per il faraone prima di avventurarsi nell’aldilà. In particolare, avvolti nelle fasce della mummia, furono trovati due pugnali. Uno di questi aveva la lama in oro, l’altro aveva la lama apparentemente in ferro. Fu quest’ultimo ad incuriosire subito lo stesso Carter, oltre agli egittologi di quel periodo, perché aveva pochissimi segni di ruggine, nonostante fossero passati tremila anni.
Che cosa incuriosì di quel pugnale?
Il fatto che la lama apparisse come fatta di ferro, nonostante nel periodo in cui visse Tutankhamon, il ferro non fosse ancora un materiale che riusciva ad essere prodotto: infatti a quei tempi eravamo ancora nell’età del bronzo. L’età del ferro iniziò in Asia Minore dopo il 1200 a.C., e in Egitto arrivò anche un po’ dopo. Il pugnale di Tutankhamon non è l’unico oggetto in ferro risalente ad un periodo storico precedente all’età del ferro. Sono stati ritrovati altri reperti in ferro, anche in altre civiltà, precedenti all’inizio dell’età del ferro. La domanda in tutti questi casi è se si tratti di ferro di origine meteoritica o di ferro di origine terrestre ottenuto casualmente durante la fusione del bronzo. Sicuramente quello che è certo è che ai tempi di Tutankhamon gli oggetti in ferro erano così rari da essere considerati di estremo valore, ancora più di quelli in oro.
La questione era quindi di indagare l’origine del ferro: si trattava di ferro meteoritico o di ferro terrestre di cava?
Sì. Ed è una storia lunga, perché già nel 1973 il ricercatore Bjorkman fece riferimento ad una possibile origine meteoritica del ferro della lama del pugnale, senza però portare una giustificazione scientifica per la sua affermazione. Successivamente, nel 1994 fu eseguita un’indagine fatta con la spettroscopia di fluorescenza X (XRF spectroscopy) che indicò che il metallo non era di origine meteoritica. Il mistero continuò nel 2010, quando alcuni ricercatori di Pisa scoprirono che il cratere Kamil in Egitto fu creato dall’impatto di un meteorite ferroso. Si ipotizzò allora che proprio i frammenti di quel meteorite in ferro potessero essere stati usati dagli antichi egizi per fare il pugnale.
Quali sono le metodologie scientifiche che possono aiutarci a svelare questo mistero?
Il ferro meteoritico può essere distinto dal ferro terrestre prima di tutto per la sua microstruttura. Però, per poterla analizzare, andrebbe fatto un micro-prelievo, cosa che sicuramente non è possibile fare su un pugnale prezioso come quello di re Tutankhamon.
Un’altra possibilità è quella di studiare la composizione chimica del ferro. Se è ferro meteoritico saranno presenti elementi particolari tipici solo del ferro meteoritico. Questa operazione può essere fatta con la tecnica di spettroscopia di fluorescenza X, che ha il grosso vantaggio di servirsi di strumentazioni portatili.
Con questa tecnica si irradia il materiale con una radiazione incidente ad alta energia, tipicamente raggi X, eccitando l’atomo che espelle elettroni dagli orbitali più interni. Gli elettroni espulsi lasciano una lacuna, il materiale si trova in una configurazione di non equilibrio per cui alcuni degli elettroni degli orbitali più esterni vanno a riempire la lacuna facendo un salto energetico, quindi cedendo energia che può essere rilevata, e che è caratteristica per ogni singolo materiale. Registrando le varie energie emesse, è possibile ottenere uno spettro di fluorescenza X, che riporta picchi ben precisi, ognuno associato a un certo elemento chimico. È quindi una tecnica che permette di conoscere quali elementi chimici sono presenti in un dato materiale.
Nel dicembre 2004 abbiamo potuto impiegare questa tecnica di indagine sulla lama del pugnale conservato al Museo Egizio del Cairo. Le indagini hanno indicato che la lama del pugnale è fatta – oltre che di ferro – di un’alta percentuale di nickel (pari a circa il 10%). È proprio questa alta percentuale di nickel, insieme alla presenza di tracce di cobalto, la “spia” che ci indica che abbiamo a che fare con ferro meteoritico. Possiamo a questo punto dire che il pugnale di Tutankhamon è stato effettivamente realizzato con frammenti di un meteorite ferroso, anche se probabilmente non con quello del cratere Kamil.
Interessante è anche l’esistenza di un geroglifico che fu coniato intorno al 1300 a.C.: “bia-n-pet”, ovvero “ferro dal cielo”. Fa supporre che gli antichi egizi fossero consci del fatto che questi frammenti di metallo arrivassero dal cielo e andassero considerati come un dono prezioso, così prezioso da essere destinato a un faraone molto amato come Tutankhamon.

Rimane ancora aperta una domanda su chi abbia realizzato il pugnale donato a Tutankhamon
Ci sono dei documenti diplomatici egiziani, le lettere di Amarna, che raccontano come il re di Mitanni avesse inviato preziosi oggetti in ferro ad Amenofi III, il nonno di Tutankhamon. Nell’elenco compaiono anche pugnali con lama di ferro e un braccialetto in ferro e oro. Si ipotizza quindi che quel pugnale trovato nel sarcofago fosse in realtà un dono della vicina civiltà dei Mitanni al nonno di Tutankhamon, poi lasciato al nipote quando morì. Un recente studio sembra confermare questa ipotesi, perché oltre ad analizzare la lama, analizza anche il manico del pugnale, e i materiali trovati nel pugnale indicano una tecnologia di preparazione che non era tipica della civiltà egiziana di quel periodo.
Torniamo a Milano, alla Biblioteca Trivulziana…
Dietro richiesta dei curatori abbiamo analizzato un piccolo stemma contenuto in una pagina di un manoscritto del quindicesimo secolo chiamato Salterio. A questi esperti, appariva strano uno stemma di qualità minore contenuto in un manoscritto così ben curato, e si chiedevano se non fosse stato ridipinto. Lo stemma, in questo genere di libri, ha una funzione fondamentale, ossia indicare la proprietà del libro.

Credit: © Biblioteca Trivulziana, Milano
Che tecniche avete usato in questo caso?
Abbiamo utilizzato tre tecniche non invasive: la riflettografia infrarossa, la spettroscopia di fluorescenza X e la spettroscopia Raman.
La riflettografia infrarossa è una tecnica che prevede di illuminare una superficie con luce infrarossa, come quella di una comune lampadina alogena, e con una telecamera sensibile alla radiazione infrarossa verificare cosa si vede. Rispetto alla radiazione visibile, la radiazione infrarossa riesce a penetrare in un dipinto per strati più profondi; quindi, in genere viene usata per mettere in evidenza il disegno preparatorio di un dipinto, i pentimenti nella realizzazione e in generale per vedere quello che c’è sotto lo strato pittorico più superficiale.
La riflettografia infrarossa dello stemma ha messo in luce la presenza di uno stemma sottostante con le sembianze di un leone. In araldica, però, un aspetto molto importante è quello dei colori. Uno stemma con leone può ad esempio appartenere a diverse famiglie, a seconda dei colori che sono stati utilizzati.
Per scoprire quali pigmenti fossero stati utilizzati nello strato sottostante, l’abbiamo esaminato con la fluorescenza X utilizzata come tecnica di mapping, per identificare gli elementi chimici, e con la spettroscopia Raman, una tecnica di spettroscopia molecolare che ci indica invece quali composti molecolari sono presenti.
Cosa avete scoperto?
Dalla combinazione delle due tecniche spettroscopiche abbiamo evidenziato che lo stemma superiore, non originale, è stato realizzato con blu oltremare e con minio, un pigmento rosso aranciato a base di piombo. Lo stemma sottostante invece è fatto di un bordo realizzato in cinabro, un pigmento rosso a base di mercurio, e di un leone bianco, realizzato con il pigmento biacca, su uno sfondo azzurro realizzato in azzurrite.
Grazie all’identificazione dei colori, abbiamo potuto riconoscere lo stemma in quello riportato sulla copertina del ritratto del vescovo Bernardo de’ Rossi, che quindi era il proprietario originario del manoscritto in questione.
Ci parli dello studio sulle vetrate della chiesa di Santo Spirito a Milano
Lì abbiamo utilizzato una tecnica di imaging molto interessante: l’imaging iperspettrale. Questa tecnica, sviluppata ed ottimizzata nel corso degli ultimi 20 anni, ad oggi viene usata in svariati campi di applicazioni, ad esempio in biologia e in medicina, nel settore industriale per lo studio di contaminanti nei cibi, , ma anche come tecnica remota montata su satelliti o aerei per il monitoraggio della vegetazione. Negli ultimi anni la tecnica ha trovato interessanti applicazioni nella diagnostica per i Beni Culturali.

Premettiamo che un’immagine in bianco e nero è un’immagine a singola banda, mentre un’immagine a colori, fatta con una comune macchina fotografica, è formata da tre canali, i cosiddetti colori rgb (red, green and blue). Alla base dell’imaging iperspettrale c’è la moltiplicazione del numero di bande dello spettro della luce che andiamo a studiare, che da tre possono diventare un centinaio. In questo modo si combina la semplicità ed immediatezza di una tecnica di imaging con la potenzialità di una tecnica di spettroscopia.
Per le bellissime vetrate della chiesa di Santo Spirito non abbiamo usato nessuna lampada, ma abbiamo sfruttato una bellissima giornata di sole. Abbiamo osservato lo spettro della luce trasmessa dalla vetrata con la telecamera iperspettrale, osservando, come ovvio, che i vetri di diverso colore danno una risposta diversa. È quello che sperimentiamo con i nostri occhi riconoscendo i colori.
Ma la telecamera iperspettrale serviva per dimostrare che tasselli all’apparenza uguali, ad esempio tasselli blu, in realtà erano diversi tra loro, avevano uno spettro di trasmissione differente. Non lo notiamo ad occhio nudo perché il fenomeno avviene nel vicino infrarosso. La spiegazione è che probabilmente si trattava di vetri sostituiti rispetto agli originali.
Arriviamo al tema della pittura moderna…
Il periodo che va da fine 1800 a inizio 1900 è molto interessante dal punto di vista dei cambiamenti nei materiali a disposizione dei pittori.
Una prima invenzione è quella del tubetto dove poter trasportare il colore. Fu un ritrattista americano a inventarli, nel 1841. Era John Rand, a cui venne l’idea dei tubetti di metallo morbido, gli stessi che usiamo oggigiorno, per sostituire certi pacchetti di vescica di maiale, dove venivano fino ad allora conservati i colori a olio. Una confezione che non riusciva a evitare che seccassero in fretta. Questa novità si dimostrò importante soprattutto per gli Impressionisti che amavano dipingere all’aperto, ma anche per i pittori a loro successivi. Renoir stesso osservò che “senza i tubetti di colore non ci sarebbero stati Cézanne, Monet, Sisley o Pissarro, niente di ciò che i giornalisti avrebbero chiamato Impressionismo”… e probabilmente neppure Renoir.
Ma ci fu un’ulteriore innovazione per i pittori di quel periodo: si tratta dei pigmenti moderni, creati per sintesi chimica grazie all’innovazione nell’industria della chimica portata dalla Seconda Rivoluzione Industriale. Alcuni esempi di questi pigmenti moderni sono il bianco di zinco, il giallo e il rosso di cadmio e il giallo di cromo. Questi colori presentavano una brillantezza cromatica e un potere coprente molto superiore a quella dei pigmenti tradizionali e, grazie a queste proprietà, furono usati intensamente dai pittori dell’epoca. Fu solo successivamente che si scoprì che alcune formulazioni di questi pigmenti non erano molto stabili perché frutto di metodi di sintesi non ancora perfezionati.
È quindi tipico della pittura moderna il presentarsi di alcuni fenomeni di degrado, come protrusioni, crepe, essudazioni o sbiadimenti.

Credit: © Fondazione Bayeler, Basilea.
Abbiamo avuto l’opportunità di studiare queste degradazioni su “Femme”, un dipinto di Picasso attualmente conservato a Basilea alla Fondazione Bayeler. Il dipinto risale al 1908, ed è probabilmente uno studio per una delle sue opere più famose, “Les demoiselles d’Avignon”. Da un confronto di una fotografia del dipinto Femme fatta nel 2014 con una del 1965 è risultato che le stesure gialle hanno mantenuto il loro colore nella parte centrale del dipinto, mentre le zone più laterali hanno chiaramente cambiato il loro colore virando in una tonalità marrone e più sbiadita.
Abbiamo condotto una serie di analisi spettroscopiche e di imaging sia direttamente sul dipinto, sia su due frammenti microscopici di pittura prelevati dal dipinto. Le analisi hanno evidenziato che in realtà le due stesure gialle sono fatte di uno stesso pigmento, il giallo di cadmio, ma probabilmente ottenute da due tubetti di colore di qualità differente. I due gialli di cadmio, provenienti da due tubetti diversi ed esposti alle stesse condizioni ambientali durante la vita del dipinto, si sono quindi modificati in maniera diversa: uno è rimasto stabile nel tempo, l’altro è chiaramente degradato.
Come avete valutato la differenza tra le due pitture?
La tecnica che ci dà queste informazioni è una tecnica di indagine della fluorescenza ottica emessa: si illumina il dipinto con luce ultravioletta e si fa una fotografia della radiazione che viene riemessa dal dipinto. Il giallo degradato ha un’emissione quasi aranciata, mentre quello sbiadito ha un’emissione molto più debole e di un colore più cupo. Questo ci indica materiali differenti, sebbene siano entrambi gialli di cadmio.
È interessante notare che altri dipinti moderni realizzati con giallo di cadmio hanno mostrato, in presenza di degrado, la formazione di una fluorescenza aranciata simile. La domanda che ci siamo posti è stata quindi quale sia la causa di questa fluorescenza aranciata, se possa essere un indicatore utile per capire la presenza del degrado del giallo di cadmio e, ultimo, ma non ultimo, perché alcune formulazioni di giallo di cadmio siano più stabili di altri.
Qual è l’origine di questa emissione aranciata?
Per capirlo, abbiamo misurato di nuovo questa emissione ottica, andando però a vedere per quanto tempo permane. Semplificando, ci siamo chiesti se si tratta di una fluorescenza – più breve – o di una fosforescenza che permane per più tempo. Con un rivelatore ci siamo accorti che dura per qualche microsecondo, quindi assomigliava più a una fosforescenza, molto più intensa nella zona dove c’è il giallo degradato. Questo ci ha fatto pensare che il pigmento utilizzato avesse dei difetti nella struttura cristallina, cioè che fosse un’emissione da “stati trappola” indotti dalla presenza di difetti cristallini.

Credit: © Fondazione Bayeler, Basilea.
Ci spieghi meglio…
Il giallo di cadmio, presente in svariate tonalità, è fondamentalmente basato sul semiconduttore solfuro di cadmio, dal quale aggiungendo zinco dentro la struttura cristallina si ottengono le tonalità più chiare, mentre aggiungendo selenio si ottengono quelle più scure. La cosa interessante è che i dipinti che mostrano questo degrado sembrano essere tutti i dipinti del periodo storico all’inizio del processo di sintesi di questo colore, quando probabilmente non era ancora stato ben affinato il processo di sintesi.
Il giallo di cadmio è un semiconduttore in cui atomi di zolfo e di cadmio si alternano in una struttura cristallina ben precisa. Ma quando sintetizziamo un materiale cristallino è naturale che si formino dei difetti dentro la struttura, sia per difetti nel processo di sintesi che per l’interazione con altri materiali.
Questi difetti creano livelli energetici detti stati trappola, che possono dare luogo ad un’emissione ottica proprio come quella evidenziata sul dipinto di Picasso.
La conclusione è che la stesura che si è degradata è fatta sempre di solfuro di cadmio, ma ha una presenza di difetti cristallini molto più elevata di quella presente nella stesura non degradata, dando luogo a un’intensa emissione “di fosforescenza”.
Studiando la letteratura abbiamo provato a dare una spiegazione sulla particolare emissione di colore arancio presente nella stesura degradata: sembra che più i cristalli di solfuro di cadmio sono piccoli, più l’energia delle emissioni si sposta verso il basso, spostandosi dall’infrarosso al rosso-arancio. L’ipotesi, supportata anche dallo studio del giallo di cadmio degradato nel dipinto “L’urlo” di Munch, è che il giallo di cadmio in questione contenga particelle nanocristalline di solfuro di cadmio, nanoparticelle molto più reattive, caratterizzate da un’alta densità di difetti superficiali, e più facilmente soggette ad un degrado.
Dev’essere stata una ricerca molto complessa…
Quest’ultima ricerca è probabilmente la più complessa tra quelle raccontate. Nonostante la sua complessità, ci avvicina all’affascinante mondo dei solidi cristallini e dei difetti delle strutture cristalline, un settore di studio che mi ricorda una bellissima frase di Colin Humphreys:
Crystals are like people: it is the defects in them which tend to make them interesting!
I cristalli sono come le persone: sono i loro difetti che li rendono interessanti!