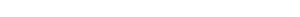Dal Politecnico di Milano all’Antico Egitto il passo è breve: il nostro ateneo, infatti, dal 2018 ha stretto un rapporto di collaborazione con la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (Museo Egizio) per valorizzare il patrimonio museale da un lato, ma anche dare agli studenti e ai ricercatori del Politecnico la possibilità di contribuire a questa valorizzazione. Un lavoro che attraverso l’ambito delle digital humanities sta portando i suoi frutti. Ma in cosa consiste? Come si sta sviluppando? Lo abbiamo chiesto alla coordinatrice del progetto, Corinna Rossi, professoressa di Egittologia e Civiltà Copta al Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito.
Professoressa, ci racconti un po’ del suo percorso accademico e professionale che l’ha portata ad occuparsi di antico Egitto
«Sono appassionata di Antico Egitto fin dalle elementari, ricordo ancora l’illustrazione delle Piramidi di Giza sul sussidiario e quando le ho visitate a 13 anni.
Al momento dell’iscrizione all’università ho scelto architettura, perché mi permetteva di studiare allo stesso tempo materie scientifiche e materie umanistiche, e ho intrapreso la strada della storia dell’architettura laureandomi con una tesi sull’Antico Egitto. A quel punto ho deciso di specializzarmi in egittologia. Mi sono spostata in Inghilterra, a Cambridge, per 7 anni, dove ho seguito un master in egittologia, poi un dottorato e sono rimasta come junior research fellow al Churchill College.
Dopo la nascita delle mie due figlie, ho vinto un ERC Consolidator Grant e la mia vita ha avuto una svolta, stabilizzandomi al Politecnico di Milano. A distanza di sei anni, il bilancio che posso fare è estremamente positivo: il Politecnico è stato in grado di accogliermi nella maniera migliore, dando spazio a quelle che erano le mie peculiarità di persona che lavora combinando vari settori disciplinari. L’ambito in cui noi ormai ci muoviamo è quello delle Digital Humanities: accosto continuamente pezzi diversi di ricerca per capire se funzionano e come».

Politecnico di Milano e antico Egitto: una connessione inedita.
«Nell’immaginario collettivo l’egittologo è una sorta di tuttologo, una visione tramandata da questi primi 200 anni della nascita della materia con la decifrazione dei geroglifici. Non ci aspettiamo, però, un unico professore che insegni tutti gli aspetti della cultura greca, o romana. In realtà noi egittologi ci siamo evoluti in tante direzioni diverse all’interno della nostra comunità: c’è chi si occupa di questioni più tecniche, chi scava sul campo… è una comunità estremamente sfaccettata.
L’aspetto più “tecnico” della ricerca sull’Antico Egitto si sta sviluppando grazie a persone che mescolano ambiti disciplinari diversi portando un contributo alla comprensione della disciplina. È interessante capire quali possono essere le azioni nuove che possono essere intraprese con questi strumenti nuovi e stabilire un dialogo tra nuove tecnologie e archeologia in cui quest’ultima non sia un recettore passivo dell’innovazione».

Com’è nata la collaborazione con il Museo Egizio di Torino? Quali sono i risultati raggiunti finora?
«Il Museo Egizio è un museo speciale e grazie al suo direttore Christian Greco è un’istituzione che ha ribaltato il concetto stesso di museo avviando un percorso che sicuramente ha ottenuto già dei frutti e ne porterà altri.
Il museo ha una collezione di oggetti che sono tutti “muti” e il modo di farli “parlare” è recuperare le informazioni da essi e comunicarle all’esterno.
I reperti hanno più di una storia: sono stati creati da qualcuno, usati da qualcun altro e poi persi, dimenticati, seppelliti, riposti. Sono stati ritrovati per dei motivi da certe persone, sono stati studiati o meno, sono stati nascosti, venduti, sono finiti in un museo e adesso sono in una vetrina di questo museo.
Spesso utilizziamo l’espressione “pezzo da museo”, per indicare oggetti fuori moda. Invece il museo è un luogo attivo, di ricerca, che può completare la tradizionale attività didattica. La nostra collaborazione permette appunto di far entrare delle competenze esterne e dare a esse un campo di applicazione, un match assolutamente perfetto. Cerchiamo di studiare anche il modo di coinvolgere i vari tipi di pubblici del museo.
Per quanto riguarda l’antico Egitto, ci sono due aspetti che sono davvero molto difficili da comunicare al pubblico. Il primo è il tempo: la civiltà egiziana copre circa 30 secoli di storia, 3000 anni, sono veramente tanti. Il secondo è lo spazio, cioè la ri-contestualizzazione. Noi vediamo questi oggetti sempre separati dal loro contesto originario.
Le nuove tecnologie possono rappresentare una chiave di lettura in più, attraverso la sperimentazione, e l’università è l’ambito ideale per fare questo. Con il Museo Egizio di Torino abbiamo instaurato questa collaborazione estremamente fruttuosa, in cui sperimentiamo insieme, ascoltiamo i loro bisogni a cui proviamo a proporre soluzioni, ma anche proporre qualcosa di nuovo da testare per aprire inedite direzioni di ricerca. Un’interazione estremamente produttiva, incentrata sul risultato scientifico.
Abbiamo realizzato una serie di modelli tridimensionali di oggetti che sono stati utilizzati sia a scopo divulgativo che di ricerca. Per esempio, il rilievo submillimetrico del sarcofago di Butehamon, che abbiamo realizzato nel 2018, è stato uno dei cardini intorno a cui si è realizzata un’installazione di video mapping della mostra “Archeologia invisibile”, che adesso è in esposizione a Vicenza.
Sul campo abbiamo supportato il Museo a Saqqara su una serie di tombe del Nuovo Regno, sperimentando il rilievo tridimensionale dello scavo stratigrafico. Abbiamo identificato nel tempo insieme a loro un workflow da adottare per la registrazione in tridimensionale dello Stato dello scavo stratigrafico».
Ha citato Saqqara, lì gli archeologi egiziani hanno appena trovato una nuova tomba. Proprio in una di queste tombe è stata rinvenuta una mummia appartenuta ad un uomo di nome Hekashepes che visse circa 4.300 anni fa. Ci sono tanti tesori ancora nascosti?
«Assolutamente sì. Noi seguiamo i tecnici del Museo nello scavo e ci torneremo con loro nei prossimi mesi. Si ritiene che in epoca moderna sia stata esplorato solo 1/3 della necropoli. Ovviamente non è detto che i 2/3 rimanenti siano tutte tombe intatte, tutt’altro, ma c’è ancora tantissimo da scoprire.
La riflessione in realtà non è su cosa troveremo ma fino a quando continuare a scavare tutta la necropoli: lo scavo archeologico è un’operazione distruttiva a cui si accompagna un lavoro di conservazione degli oggetti, di comunicazione all’esterno, per evitare l’oblio di ciò che è stato rinvenuto. Il ragionamento riguarda soprattutto i resti umani perché sono di persone che hanno speso tempo, energia e denaro dell’epoca per essere seppellite in una tomba dove vivere la loro vita eterna, la “Casa per l’eternità” come la chiamavano. Ci sono decine, centinaia, migliaia di reperti scavati negli ultimi due secoli che giacciono nei magazzini dei musei, magari potremmo valorizzare e studiare di più anche quelli.
A questo negli anni si è aggiunto il dibattito sulla restituzione dei reperti. La maggior parte dei reperti dei musei sono stati raccolti quando nell’Ottocento non c’era nessun divieto di scavo, o nella fase successiva, del cosiddetto “partage”, l’obbligo di distribuzione equa tra Egitto e paese di destinazione. Ora c’è il divieto assoluto di esportazione. Anche la restituzione in massa degli oggetti comporta dei problemi, perché in realtà fanno anche parte della storia del paese colonizzatore: se esso restituisce tutti gli oggetti, dimentica di essere stato colonizzatore. Il problema del decolonizzare l’archeologia non si risolve banalmente riportando gli oggetti nei luoghi di origine, perché i musei comunque investono annualmente risorse e competenze avanzatissime nella conservazione ottimale di questi oggetti».
Dal punto di vista della digitalizzazione del Museo Egizio state lavorando su qualche progetto in particolare?
«Il punto fondamentale è che l’oggetto deve restare centrale. Un processo di digitalizzazione per produrre immagini digitali degli oggetti è una pratica di documentazione utile, ma che non si può ridurre alla scansione a tappeto e la realizzazione di immagini tridimensionali. Il rilievo, l’analisi archeometrica, la modellazione dell’oggetto sono il punto di partenza per la ricerca non il punto d’arrivo: questi strati archeologici tridimensionali come li visualizziamo? Come li sezioniamo? Come tiriamo fuori le informazioni? Un problema che da egittologico è diventato informatico.
Vedo la realtà aumentata più proficua e più immediatamente attuabile della realtà virtuale. Di quest’ultima si sottostimano sempre i costi di realizzazione e il lavoro enorme di digitalizzazione per iniziare, ma poi anche di costruzione dei contenuti, che non sono i classici contenuti scritti. Il tema è reclutare nuove professionalità».

Anche nella mostra “I creatori dell’Egitto eterno”, in corso a Vicenza, avete utilizzato la tecnologia?
«Ci siamo fatti ispirare dalla mostra dell’anno precedente, “La fabbrica del Rinascimento”, che trattava di come a Vicenza si fosse creata l’unione tra sapere tecnico e visione umanistica. Abbiamo pensato a una mostra incentrata sugli operai delle tombe della valle dei Re perché erano coloro che combinavano la sapienza tecnica con la possibilità di realizzare queste tombe paradigmatiche: la tomba del faraone era quella più importante di tutte e che quindi doveva rassicurare, rappresentare il passaggio da questa vita a quella eterna. Un secondo aspetto era la necessità di dialogare con la Basilica Palladiana. La mostra è stata pensata per avere gli oggetti disposti in un percorso, la vita prima della morte, e dall’altro lato la vita dopo la morte. Tre installazioni multimediali sviluppano, aprono una finestra, permettono al visitatore di guardare oltre la mostra, ma partendo dagli oggetti. La prima installazione multimediale è proprio all’ingresso del percorso espositivo con un viaggio video realizzato con Google Earth, dalla Basilica di Vicenza fino in Egitto che è contemporaneamente viaggio nel tempo. L’allestimento ha 5 stendardi verticali che puntano verso l’alto sui quali il direttore stesso ha scelto le frasi da scrivere, come 5 segnalibri in geroglifico che scandiscono il racconto.
Su uno di questi è stato cioè proiettato un video muto, mentre su un altro c’è proiettato invece il video realizzato da Robin Studio sul Papiro 1885, la pianta della tomba di Ramses IV in cui invece si vede questa trasformazione della tomba.
Nel punto in cui si passa dalla vita alla “vita eterna” abbiamo deciso di posizionare un sarcofago con la mummia al suo interno, il culmine della materialità. Il sarcofago di Tariri è messo accanto ad un altro sarcofago vuoto. Un momento che porta a riflettere sul fatto che con gli scavi si va comunque ad aprire una necropoli, un luogo sacro.
Il clou della mostra è l’installazione completamente virtuale di video mapping sul sarcofago di Butehamon, che racconta di come questo sarcofago in realtà sia composto di vari pezzi messi insieme, compresi pezzi di altri sarcofagi e fa riflettere sulla funzione del sarcofago.
Entrambi i video sono disegnati sulla musica di Hans Zimmer, con le colonne sonore di Interstellar e Inception. La musica in questo caso non è mero sottofondo ma parte integrante della narrazione».

Abbiamo parlato della sua collaborazione con il Museo Egizio di Torino, ma lei è coinvolta in un altro grande progetto, LIFE (Living in a Fringe Environment) che vede lavorare insieme il Polimi con l’Università Federico II di Napoli. In cosa consiste questo progetto? Quali saranno gli sviluppi futuri?
«Il progetto LIFE è finanziato dall’ERC Consolidator Grant che ho avuto la fortuna di vincere nel 2015 e si concentra su un sito archeologico un po’ inusuale rispetto all’Egitto conosciuto dal grande pubblico. Si tratta infatti di un insediamento fortificato Tardo-Romano costruito non lungo la Valle del Nilo, ma nel deserto occidentale, lungo quello che all’epoca era il confine dell’Impero Romano.
Il nome moderno del sito è Umm al-Dabadib, e si trova a 50 km di distanza dalla cittadina di Kharga, la capitale dell’omonima oasi. Ci si arriva utilizzando una pista che corre tra sabbia e rocce, le cui tracce vengono periodicamente cancellate dalle tempeste di sabbia. Il sito è annidato ai piedi della scarpata che chiude l’oasi a nord, dove la falda acquifera è più accessibile. Benché non ci sia acqua affiorante, il sito è ricco di vegetazione e alberi millenari.
I resti archeologici comprendono un insediamento del primo periodo Romano, e poi un altro del Periodo Tardo, stretto attorno ad un fortino con due torri quadrate alte 12 metri. Una delle due contiene ancora la scala che portava su ad una finestra dalla quale si controllava tutta la piana meridionale, oltre la quale iniziava il territorio che non era più sotto il controllo Romano.
Gli insediamenti costituiscono solo metà dei resti archeologici: controparte fondamentale della presenza della comunità era l’imponente sistema agricolo che permetteva alla comunità stessa di vivere lì, che comprendeva un elaborato sistema di acquedotti sotterranei che portavano l’acqua ai campi per gravità e una vasta area coltivata. È interessante notare come il reticolo dei campi sia praticamente invisibile sul posto tranne che in un momento particolare della giornata, ovvero per pochi minuti al tramonto se il sole radente non è coperto da nuvole o sabbia in sospensione. Altrimenti sono perfettamente visibili dalle immagini satellitari.
La compresenza simmetrica di ambiente costruito e sistema agricolo si riflette nell’organizzazione del progetto: il Politecnico di Milano studia l’insediamento e la cultura materiale ad esso appartenente, mentre i Musei delle Scienze Agrarie dell’Università Federico II di Napoli studiano il sistema agricolo nella sua interezza. Questi due elementi erano come due facce della stessa medaglia, visto che l’uno non poteva esistere senza l’altro e l’uno era la ragion d’essere dell’altro.
Il progetto ERC è ormai giunto al termine, ma lo studio e la ricerca incentrati su Umm al-Dabadib continueranno: il progetto finanziato dalla Comunità Europea ha dato i suoi frutti, e questi frutti a loro volta hanno prodotto altri semi, che germoglieranno nel prossimo futuro. Tra tutte le scoperte che potrei ancora fare lì, una mi interessa più di altre: scoprire il nome antico del sito, che ancora non conosciamo».