Il progetto NBSouth, vincitore del Polisocial Award 2022, ha trasformato una piazza abbandonata a Paranoá, Brasile, in una cintura verde resiliente: un luogo che cattura l’acqua piovana, favorisce la biodiversità e diventa cuore pulsante della comunità locale.

Il professor Fabiano Lemes de Oliveira, Docente al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, ci racconta come, combinando nature-based solutions e partecipazione locale, il progetto abbia superato sfide tecniche e sociali, generando benefici concreti e duraturi.
NBSouth mostra che integrare la natura nella progettazione urbana non solo risolve problemi immediati, ma crea città più resilienti, sostenibili e vivibili, offrendo un modello replicabile ovunque.
Inizierei subito con una domanda di contesto: che cosa sono le Nature-Based Solutions?
Le soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions, NBS) sono interventi ispirati ai processi naturali che ci aiutano ad affrontare diverse sfide ambientali e sociali. Vengono adottate soprattutto come strumenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici, ma hanno un ruolo cruciale anche nel contrasto alla perdita di biodiversità e nel rafforzare la resilienza urbana. Sono interventi multifunzionali, capaci di fornire contemporaneamente più benefici, e risultano spesso anche più convenienti dal punto di vista economico.
Ci sono esempi di queste soluzioni che vengono utilizzati più comunemente?
Sì, ce ne sono molti. Alcuni esempi diffusi in ambito urbano sono i tetti verdi, le facciate vegetali, i giardini pluviali e i sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDs). Nel nostro caso abbiamo sviluppato una tipologia innovativa, che integra e potenzia modelli già esistenti.
Di che cosa tratta il progetto di ricerca NBSouth? Quale tecnica basata sulle Nature-Based Solutions avete utilizzato?
Prima di entrare nei dettagli tecnici, è utile raccontare il progetto nel suo insieme. Ci siamo concentrati sulla gestione delle risorse idriche e sulla mitigazione delle alte temperature in aree urbane densamente edificate. Un altro aspetto fondamentale è stato quello della biodiversità: il progetto si è svolto in un’area del cerrado, un ecosistema tropicale ricco e fragile. Per questo motivo abbiamo collaborato strettamente con gli stakeholder locali, così da sviluppare una soluzione adattata al contesto e replicabile anche in territori simili.
A Paranoá abbiamo co-progettato con la comunità una “cintura verde resiliente”, pensata per catturare, filtrare e assorbire l’acqua piovana. Questa include trincee di infiltrazione e giardini pluviali, organizzati in un sistema che permette una gestione integrata delle acque. Oltre all’aspetto idrico e di riduzione delle temperature urbane, il progetto ha avuto come obiettivo l’incremento della biodiversità locale e il rafforzamento del tessuto sociale: volevamo che l’intervento fosse non solo tecnico, ma anche uno spazio di incontro e identità per la comunità (placemaking).
La cintura verde resiliente che abbiamo realizzato non è un semplice giardino pluviale: è stato progettato in modo mirato per ottimizzare la cattura, la filtrazione e l’assorbimento delle acque meteoriche, garantendo al tempo stesso benefici ecologici e sociali.

Entriamo ora nella parte più tecnica: come funziona esattamente questa “cintura verde resiliente”?
Il progetto è partito da una piazza abbandonata, impermeabilizzata da asfalto e cemento, con pochissimo verde e una strada cieca. Abbiamo deciso di trasformarla in uno spazio permeabile, rimuovendo il vecchio pavimento e riprogettando completamente l’area.
Dopo aver calcolato la quantità di acqua che il sistema avrebbe dovuto gestire – proveniente sia dalla piazza sia da edifici vicini come il centro comunitario – abbiamo stabilito che fosse necessario scavare tra 1,5 e 2 metri di profondità. Una volta rimosso l’asfalto, abbiamo posato uno strato di tessuto geotessile per proteggere i successivi livelli di materiali:
- Ghiaia, per favorire il drenaggio.
- Suolo ingegnerizzato a base sabbiosa e arricchito con compost, utile per trattenere e filtrare l’acqua.
- Piante locali del cerrado, selezionate con la comunità per rafforzare il legame con l’ecosistema del luogo.
In questo modo, la cintura verde non solo riduce il rischio di allagamenti e migliora il microclima urbano, ma diventa anche un ambiente ricco di biodiversità e un nuovo spazio sociale per la comunità.


Per quale motivo avete scelto proprio il distretto di Paranoá?
La scelta è avvenuta insieme ai nostri partner dell’Università di Brasilia, che conoscevano già bene l’area e avevano condotto in passato progetti di ricerca sull’adattamento climatico in quel contesto. Questo ha rappresentato un punto di partenza prezioso: Paranoá era un luogo altamente rilevante per gli obiettivi del progetto – vista l’elevata urbanizzazione e impermeabilizzazione del suolo, e la necessità di gestire meglio le risorse idriche durante i periodi di siccità e di pioggia – e al tempo stesso avevamo accesso a una rete di contatti e stakeholder locali già attiva grazie al lavoro dell’università.
In questo senso è stata una situazione “win-win”: noi abbiamo potuto lavorare su un caso studio di grande interesse e l’Università di Brasilia ha contribuito con conoscenze, esperienze e relazioni fondamentali per portare avanti il progetto.
Quanto è importante la collaborazione con gli stakeholder locali e il co-design? Qual è stato il loro contributo?
La collaborazione è stata cruciale. L’Università di Brasilia è stata partner scientifico fin dall’inizio, aiutandoci a definire il caso studio e a coinvolgere gli altri attori locali. Ma altrettanto importanti sono stati i gruppi comunitari, in particolare il CEDEP (Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e Itapoã) e l’Associação Pioneiros de Paranoá, che hanno avuto un ruolo chiave nel mobilitare i residenti e facilitare la loro partecipazione agli incontri di co-creazione.
In teoria del co-design si parla di gatekeepers: figure che fanno da ponte tra i ricercatori e la comunità. In questo progetto CEDEP e Pioneiros hanno svolto esattamente questa funzione, aiutandoci a costruire una relazione di fiducia con i cittadini. Sono stati coinvolti in tutte le fasi: dalla definizione delle idee iniziali, alla progettazione delle infrastrutture verdi, fino alla realizzazione del progetto pilota.
Abbiamo organizzato diversi workshop in presenza a Paranoá, a cui hanno partecipato non solo i gruppi comunitari ma anche l’amministrazione locale.
Quindi i workshop sono stati fondamentali per capire i bisogni reali della comunità?
Esattamente, le visite e gli incontri sul posto sono stati fondamentali per comprendere meglio la storia della comunità e il suo rapporto con l’acqua. In passato, i lavoratori provenienti da tutto il Brasile che erano venuti per costruire il Lago Paranoá si erano insediati lungo la riva del lago. Col tempo l’insediamento crebbe, ma negli anni ’80 gli abitanti furono spostati nella nuova area che oggi conosciamo come Paranoá. Il loro precedente insediamento divenne un parco ecologico, ma nella Paranoá odierna la natura è quasi assente. Si è quindi prodotto un vero e proprio displacement, una perdita di connessione con l’ambiente naturale, che per noi era essenziale riconoscere.
Abbiamo così scoperto quanto fosse sentito il valore del cerrado dagli abitanti di Paranoà, con le sue piante, i fiori e i frutti locali. Si tratta di aspetti che noi non conoscevamo e che sono emersi proprio dalle discussioni con la comunità, insieme alla loro volontà di trasformare la situazione locale.
È stato però un processo bidirezionale: non voleva essere un semplice “ascoltare e fare ciò che la comunità chiede”, ma dialogare attivamente per costruire insieme le soluzioni. Nei workshop abbiamo introdotto anche i temi del cambiamento climatico e dell’adattamento, che inizialmente non erano tra le loro priorità. Gli abitanti chiedevano soprattutto spazi ricreativi e più verde, e noi abbiamo cercato di mostrare loro come questi obiettivi possano integrarsi con strategie di resilienza climatica.
Il risultato è stato un vero win-win: da un lato la comunità ha acquisito maggiore consapevolezza dei rischi legati al cambiamento climatico, dall’altro noi abbiamo potuto integrare le loro esigenze quotidiane di socialità e natura. Questo ci ha permesso di progettare non solo un luogo bello e accogliente per la comunità, ma anche uno spazio resiliente, ricco di biodiversità e capace di portare benefici molteplici. Credo che proprio questa relazione tra placemaking e resilienza sia uno degli esiti più preziosi del progetto.



Qual era il suo ruolo all’interno del progetto? E com’è stata gestita la collaborazione tra i diversi team?
Io ero il principal investigator del progetto e, insieme ad altri colleghi del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU) e dei dipartimenti di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) e di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA), rappresentavamo il Politecnico di Milano. Tutti hanno contribuito già nella fase di ideazione e scrittura del progetto, collaborando alla definizione dei diversi work packages e dei compiti specifici.
Il risultato è stata una forte integrazione di saperi:
- il DASTU ha portato competenze in urbanistica, pianificazione urbana, co-design e valutazione dei servizi ecosistemici,
- il DICA ha contribuito con la sua esperienza nella gestione e nel trattamento delle acque,
- il DABC ha offerto competenze nella modellazione dei sistemi urbani,
- l’Università di Brasilia ha avuto un ruolo altrettanto rilevante, apportando contributi scientifici e accademici in varie fasi del progetto.
In questo modo si è creata una squadra interdisciplinare capace di affrontare il progetto da prospettive diverse ma complementari.

Tornando al suo ruolo, ha detto che era principal investigator del progetto, da un punto di vista pratico che cosa faceva durante una giornata di lavoro?
Come principal investigator del progetto lavoravo a stretto contatto con il project manager, coordinando la gestione generale e interagendo con i responsabili dei vari work packages. Oltre a questo ruolo trasversale, ero anche work package leader del progetto pilota, che ha richiesto un impegno particolarmente intenso.
Le mie attività spaziavano dalla ricerca accademica alle responsabilità organizzative. Sul piano scientifico ho partecipato alla revisione della letteratura e allo studio di casi, attività che hanno portato anche alla pubblicazione di un libro dedicato alle Nature-Based Solutions nelle città del Sud globale. Ho seguito da vicino la progettazione degli spazi del progetto pilota, coordinando incontri e workshop sia in Italia sia in Brasile, insieme alla professoressa Maria Do Carmo dell’Università di Brasilia.
Accanto a questo lavoro accademico, c’era tutta la parte gestionale: reportistica, coordinamento delle attività, supervisione finanziaria e redazione dei documenti finali.
Infine, una parte importante del mio ruolo riguardava il supporto ai colleghi più giovani, attraverso attività di tutoraggio e mentorship. In sintesi, il mio lavoro ha unito la dimensione scientifica – ricerca, progettazione, pubblicazioni – con quella organizzativa e di leadership, indispensabile per portare avanti un progetto internazionale e interdisciplinare di questa portata.
Collegandoci alla sua esperienza accademica e lavorativa, qual è il suo profilo?
Sono architetto e urbanista, e da quasi vent’anni lavoro come professore universitario. Ho insegnato per undici anni nel Regno Unito prima di arrivare al Politecnico di Milano, dove dal 2019 svolgo la mia attività accademica. La mia carriera di ricerca è stata sempre dedicata a un tema centrale: l’integrazione della natura nella pianificazione e progettazione urbana.
Al Politecnico di Milano insegno progettazione urbana e ambientale. Nello specifico, al momento insegno al corso Urban and Environmental Design all’interno del master in Sustainable Architecture and Landscape Design presso il Polo di Piacenza e al laboratorio Urban Design Studio all’interno del corso magistrale in Architettura e Disegno Urbano.
Parallelamente all’insegnamento, porto avanti attività di ricerca. Attualmente partecipo a un progetto internazionale chiamato NatureScape, finanziato dal programma europeo Biodiversa+. L’obiettivo è studiare la governance delle Nature-Based Solutions nella fase successiva alla loro realizzazione: capire cioè come queste soluzioni possano evolversi nel tempo e come sviluppare meccanismi di governance of care.
Questo approccio considera le Nature-Based Solutions non soltanto come strumenti tecnici per affrontare il cambiamento climatico o rafforzare la resilienza urbana, ma come pratiche di cura reciproca tra comunità e natura. In questa prospettiva diventa essenziale il coinvolgimento di diversi attori – istituzioni pubbliche, comunità locali, settore privato e terzo settore – per garantire una distribuzione equa delle responsabilità e dei benefici.
Ritornando al progetto, quali sono i cambiamenti concreti che già si sono visti?
Il progetto è stato implementato da circa sette mesi e già si notano risultati significativi. Dal punto di vista ambientale, c’è stato un incremento rilevante della biodiversità: abbiamo introdotto circa 30 nuove specie vegetali e piantato oltre 1.800 nuove piantine all’interno della piazza, trasformandola completamente rispetto a com’era prima.
In passato, infatti, quello spazio era abbandonato, poco sicuro e spesso utilizzato come discarica dai residenti. Oggi, invece, la comunità è tornata a vivere la piazza, che è diventata un luogo di incontro e socialità.
Dal punto di vista idrico, non si sono più verificati episodi di inondazioni improvvise: il sistema sembra funzionare bene e la gestione dell’acqua piovana è molto migliorata.
Abbiamo inoltre previsto un piano di manutenzione di un anno, così da non limitarci all’implementazione iniziale ma garantire il tempo necessario alle piante per radicarsi e svilupparsi in modo stabile. Questo piano ci permette anche di monitorare sia l’evoluzione della biodiversità sia i nuovi usi sociali della piazza.


Ci sono anche altri risultati che vi aspettate più avanti, magari diciamo che sono meno evidenti, ma che sperate?
È una bella domanda. Alcuni risultati li vedremo solo nel medio-lungo periodo. Ci aspettiamo, ad esempio, una riduzione delle temperature urbane grazie alla sostituzione delle superfici impermeabili con aree verdi. La vegetazione, infatti, attraverso l’evapotraspirazione e l’ombreggiatura, contribuisce ad abbassare la temperatura e a migliorare il microclima: era uno degli obiettivi del progetto fin dall’inizio.
Non escludiamo inoltre che possano emergere altri benefici non previsti, legati sia agli aspetti ambientali sia a quelli sociali. Sarà interessante monitorare l’evoluzione nel tempo e capire quali ulteriori effetti positivi potranno svilupparsi.
Passando invece a una domanda più generica, secondo lei quale ruolo avranno le Nature-Based Solutions nella pianificazione urbana dei prossimi anni, cioè del futuro?
È una domanda molto interessante. Secondo me, le soluzioni basate sulla natura dovrebbero rappresentare non solo degli strumenti tecnici di risposta a problemi esistenti, ma aprire la strada a un vero e proprio pensiero basato sulla natura all’interno della pianificazione urbana.
Le Nature-Based Solutions sono fondamentali per la resilienza delle città e per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Tuttavia, per loro natura, tendono a essere reattive: intervengono cioè per risolvere un problema già presente o imminente, piuttosto che prevenirlo. Questo approccio è certamente utile, ma rischia di arrivare troppo tardi.
L’evoluzione auspicabile, secondo me, è quella di integrare i processi naturali nella pianificazione urbana in maniera proattiva e olistica, così da orientare la trasformazione delle città verso futuri paesaggi urbani più sostenibili e più equilibrati. Non si tratta soltanto di reagire a crisi ambientali già in corso, ma di ripensare in profondità la relazione tra esseri umani e natura, costruendo contesti urbani capaci di prosperare nel lungo periodo.
In altre parole, le Nature-Based Solutions non dovrebbero limitarsi a “riparare” i danni, ma diventare parte di una visione più ampia che riconosca la natura come elemento strutturale della città del futuro.
Qual è stato l’aspetto per lei più emozionante e gratificante del progetto, anche da un punto di vista umano?
Per me il momento più emozionante è stato sicuramente l’inaugurazione della piazza. Non ero presente fisicamente, ma ho seguito l’evento online e visto i video. È stato toccante assistere alle presentazioni dei membri della comunità, che hanno raccontato quanto quello spazio fosse importante per loro.
In particolare, mi ha colpito un gesto simbolico molto bello: l’abbraccio collettivo alla piazza. Tutti insieme hanno voluto esprimere con quel gesto il valore che attribuiscono al luogo e la gioia per il risultato raggiunto. È stato un momento semplice ma estremamente significativo, che ha reso evidente quanto il progetto non sia stato solo un intervento tecnico, ma anche un’esperienza di forte valore umano e comunitario.
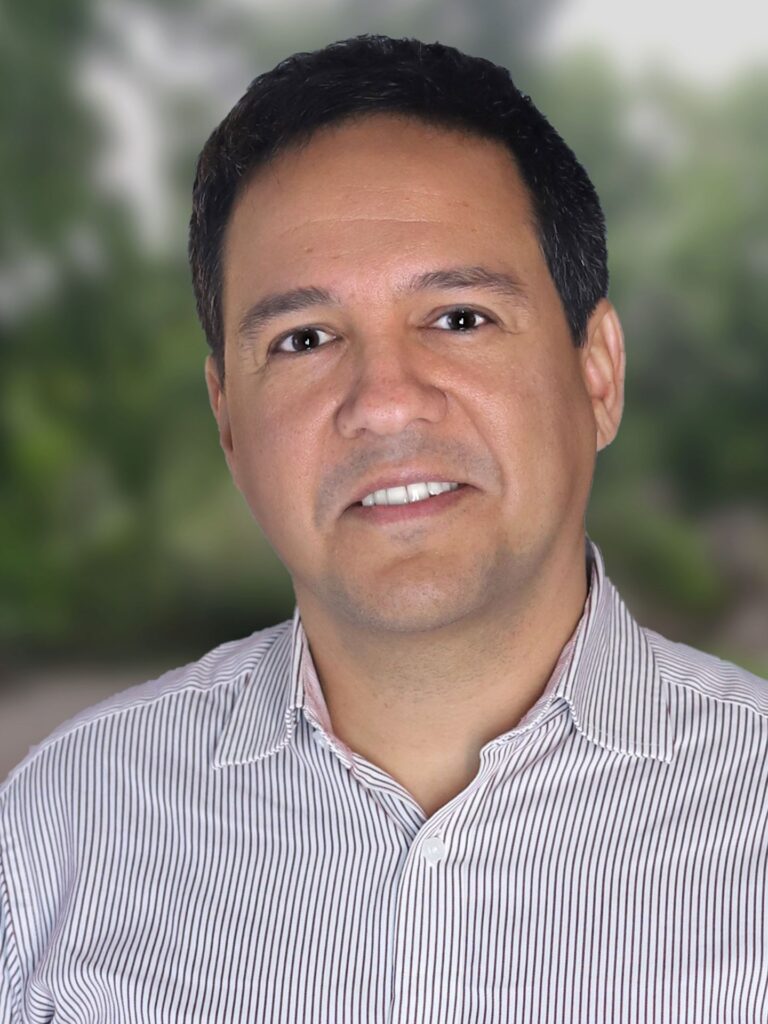
Qual è stata invece una delle sfide più importanti che avete affrontato, che l’ha messa più in difficoltà?
Le parlerò di una difficoltà principale e di una minore, ma curiosa.
La sfida più importante è stata legata agli aspetti giuridici e burocratici dell’intervento. Dopo aver progettato la piazza, abbiamo dovuto sottoporre il progetto alla pubblica amministrazione, e affrontare commenti e revisioni. Non era chiaro quanto tempo sarebbe stato necessario, e considerando che il progetto inizialmente aveva una durata di due anni, questo ha creato molta incertezza. Alla fine, siamo riusciti a ottenere una proroga, che si è rivelata fondamentale per completare l’intervento rispettando tutti i vincoli legali.
La seconda “difficoltà”, più curiosa, riguarda la gestione delle piante: avevamo scelto una specie di salvia messicana per i giardini, particolarmente apprezzata dalle formiche, al punto da divorarla completamente! Ci siamo quindi trovati a dover sostituire queste piante per colmare il vuoto lasciato, imparando a confrontarci con le sfide imprevedibili della natura stessa.
L’ultima domanda invece è se ha un consiglio da dare a giovani ricercatori che si vogliono occupare di sostenibilità e adattamento climatico.
Credo che il primo passo sia lavorare su qualcosa in cui si crede davvero. È fondamentale essere appassionati al proprio tema di ricerca: solo così si trovano le motivazioni per andare avanti anche quando il percorso è complesso. Nel campo della sostenibilità, della resilienza urbana e dell’adattamento climatico, le difficoltà sono molte, i processi spesso lenti, gli ostacoli infrastrutturali significativi. Nonostante ciò, è importante mantenere un atteggiamento positivo e la convinzione che i nostri sforzi possano davvero contribuire a risolvere i problemi.
