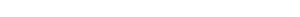“We are all one”. Siamo tutti un’unica entità. L’architettura di Anupama Kundoo è così, un inno all’umanità. E al suo essere comunità, perché secondo l’architetta indiana “abbiamo più cose in comune che tratti di diversità, non siamo diversi”. È un ribaltamento vero e proprio, come quello che fa quando parla del vuoto, un concetto con accezioni negative per molte persone. Ma non per lei: “In ogni materiale naturale c’è un vuoto all’interno. Gli spazi e i materiali devono respirare, durante la pandemia si è visto quanto sia importante la porosità in architettura. L’aria deve circolare anche in contesti che hanno poche risorse, anche nelle case molto umili”.
Ma la riflessione più interessante, forse, è quella sui materiali. Secondo Anupama “oggi i materiali di cui è fatta la nostra architettura danno più problemi ambientali, sociali ed economici che soluzioni”. Per questo è urgente ripensarli e “costruire meno, ma meglio”, come nelle parole che hanno dato il titolo a questo nostro incontro con lei. Avvenuto in occasione del 10° Premio Michele Silvers (dedicato alla memoria del giovane architetto laureatosi al Politecnico di Milano), quando la Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) ha ospitato la sua lectio magistralis. In cui Anupama Kundoo ha parlato proprio dei materiali che troviamo nelle nostre città, proponendo 12 strategie per ripensarli. Ci ha parlato di questo e di tanto altro in modo informale, generoso e appassionato. Raccontandoci il suo approccio all’architettura e sempre attenta a rispettare i bisogni del pianeta e le esigenze delle popolazioni che vivono in città sovraffollate. Ha spaziato dalle sue origini al concetto di tempo, fino a dispensare alcuni preziosissimi consigli ai giovani studenti che si affacciano al mondo del lavoro.
IL PROFILO

Nata a Pune, in India, nel 1967, e laureata in architettura all’Università di Mumbai, città in cui è cresciuta, nel 1989, Anupama Kundoo è una figura femminile di rilievo nel contesto dell’architettura internazionale. Insegna presso la Fachhochschule Potsdam in Germania e la sua attività professionale è riconosciuta e pluripremiata a livello internazionale.
L’INCONTRO CON ANUPAMA KUNDOO
Quando ha deciso di dedicarsi all’architettura? Cosa ha acceso la scintilla?
“Da ragazza amavo l’arte e pensavo di diventare un’artista. Ero curiosa e piena di interessi ma non sapevo che carriera avrei intrapreso, pensavo poi che non si deve essere definiti solo dalla propria professione. Le mie materie preferite erano matematica e geometria, ma mia madre, che aveva studiato arte, ci aveva introdotto fin da piccoli al disegno e alla pittura. Mi piaceva creare oggetti per conto mio: sculture, lavori a maglia e con i tessuti. Al momento di scegliere l’università ero indecisa fra belle arti, specialmente scultura, e matematica. In India però non è possibile studiare entrambe, sono considerate materie agli antipodi, mentre per me erano perfettamente compatibili. Fu un test attitudinale a suggerirmi architettura, una professione che non avevo mai considerato fino a quel momento. Eppure subito capii che sarebbe diventata la mia professione e da allora non ho avuto un momento di esitazione.
Essendo cresciuta a Mumbai (Bombay fino al 1995, ndr) pensavo che le persone meritassero spazi e habitat migliori ed ero molto eccitata dall’opportunità di poter contribuire a questo obiettivo. Non mi sono mai guardata indietro e anche per questo ho sempre avuto un approccio alla sintesi. L’architettura mi permetteva di mettere insieme tutti i miei interessi e non essere scissa”.
Ha viaggiato molto, insegnato e fatto ricerca in diverse città e nazioni del mondo: Berlino, Londra, New York, Australia, Barcellona, Venezia, Madrid… Ma le radici indiane non si dimenticano e hanno una forte influenza sulla sua architettura. Quali aspetti sente di portare sempre con sé?
“Ovunque io vada nel mondo sono profondamente connessa con le mie origini. Ma sono anche profondamente connessa alle origini di ciascuno perché penso che siano simili, le culture si assomigliano. Quando sono in Italia, in Germania o anche in Australia sento che ciò che mi piaceva profondamente della mia cultura mi permette di godere la profondità della cultura di quel posto. E questo è il nostro terreno comune, quello che ho cercato di spiegare anche nella mia esposizione alla Biennale di Venezia del 2012 e che David Chipperfield aveva appunto intitolato ‘Common Ground’. Posso affermare che siamo più comuni che diversi, siamo tutti un’unica entità (‘we are all one’), non siamo diversi”.
In quell’occasione Anupama Kundoo aveva parzialmente ricostruito in scala 1:1 la sua Wall House, costruita originariamente per Auroville, in India, nel 2000.
L’innovazione della Wall House si basa su un design attento all’ambiente e alla cultura locale. È stata infatti progettata con vari materiali da costruzione sostenibili, selezionati per sperimentare la natura della costruzione e l’esperienza dello spazio. La selezione varia dai mattoni alla terracotta, dai tubi a incastro fino alle bottiglie di vetro e a vari materiali riciclati.
Qui, Kundoo, ha potuto riunire i due mondi della casa, la sua posizione originale e la sua essenza, con lo spazio espositivo dell’Arsenale.

Da cosa deriva il suo uso prevalente di materiali e tecnologie naturali?
“Non amo l’innovazione fine a se stessa. Gli occhiali che ho indosso, ad esempio, hanno il loro design classico e funzionano bene. Non hanno bisogno di nient’altro. Invece quando trovo nuovi problemi da risolvere, cose che non funzionano, è lì che voglio innovare. Non mi stanco dei materiali naturali, così come in Italia non ci si stanca di mangiare la pasta (ride, ndr). Sono intorno a me, la potenzialità di essere creativi con loro è infinita. Preferisco sempre materiali che posso toccare, che respirano. Per questo cerco di utilizzare materiali naturali come legno, bambù, fibra di cocco, terra, corda, vetro…”.
La situazione delle città indiane, povere e sovraffollate, è molto critica. Con che approccio si potrebbe affrontare il problema?
“Uno dei grandi problemi delle città indiane è la forte presenza di auto private. Non solo per lo spazio che tolgono ai pedoni, ma soprattutto per il rumore e il pericolo che provocano. Anche le abitazioni moderne, però, stanno diventando sempre più care e ad alto consumo energetico, si spende troppo per la casa e molti non possono permetterselo. E così, per risparmiare, ci si accontenta di case di scarsa qualità.
Penso veramente che sia tutto capovolto e che bisogna approfittare della pandemia per fermarsi e trovare un’altra forma. Ora che non stiamo viaggiando abbiamo scoperto quanto siamo adattabili. Se cerco di utilizzare materiale riciclato e spendere di più in manodopera è perché se si spende di più nelle persone e meno nei materiali si produce meno inquinamento e tutto il budget è investito in capitale umano: questa per me è una buona strategia economica”.
Lei ricerca materiali che riducano al minimo gli impatti ambientali. Utilizza materiali di scarto e si appoggia su artigiani locali che creano e cuociono sul posto mattoni e tegole. Qual è la dimensione di innovazione e ricerca nell’utilizzare materiali e tecnologie locali e tradizionali?
“Ho intitolato la mia lecture qui al Politecnico di Milano ‘Rethinking Urban Materiality in the Era of Climate Change’ e ho proposto 12 strategie per ripensare i materiali urbani. Bisogna pensare al metabolismo di una città come a un tutt’uno. Costruire meno, ma meglio. I materiali di cui è fatta la nostra architettura oggi forse danno più problemi ambientali, sociali ed economici che soluzioni, è urgente ripensare ai materiali che utilizziamo. Ogni materiale deve essere usato nel modo migliore. Prendiamo il cemento, ad esempio: cerchiamo di usarne meno, ma di buona qualità. Usando il ferrocemento uso meno materiale. Bisogna togliere l’extra, il superfluo. È importante analizzare in maniera critica i materiali dal punto di vista di quanto fanno avanzare l’essere umano oppure no. In antropologia si dice ‘what you make it also makes you‘. Il cervello umano ragiona così, la mente è matematica attraverso questo “se fai ti fai”. Ogni azione cha facciamo ci dà forma, dobbiamo creare tracce e riconoscere che facciamo parte di un grande collettivo. Non voglio tornare indietro nella storia e difendere un approccio nostalgico alla tradizione, dico però che la produzione di materiale e le risorse e il pensare con le mani danno forma anche all’essere umano e non producono problemi ambientali. Tendo a privilegiare la conoscenza intuitiva che passa attraverso il lavoro manuale. Ho sempre cercato di guardare al mio contesto con sensibilità e a fare un’architettura sensibile. Non urlata. Produrre oggetti fotogenici che sembrano belli nei rendering non è sufficiente, bisogna sentirsi bene quando si è dentro gli spazi”.
Da cosa parte la sua ricerca di materiali e a chi si è ispirata?
“Sono stata molto influenzata da Pierluigi Nervi e dal suo lavoro sul ferro-cemento. Tutto quello che lui ha fatto con la cassaforma per rendere il cemento più efficiente e l’uso della terracotta mi ha permesso di risparmiare fino al 60% di ferro. La ricerca di Nervi mirava a ridurre il peso in maniera ingegneristica con piccoli pezzi di ferro. Io ho usato la plasticità di questo materiale per molti anni, fin dall’inizio della mia ricerca 25 anni fa. È un esempio di come si possono prefabbricare elementi modulari con elementi molto sottili, ma molto resistenti, facili da colorare e che possono essere assemblati per produrre case pratiche, impilabili, durevoli e anche belle.
Ma la mia ricerca si è ispirata anche alla pratica. Quando studiavo, a 23 anni, ho scoperto che c’erano degli artigiani che stavano perdendo il loro lavoro per colpa della crescente urbanizzazione. Volevo salvare le conoscenze sulla ceramica, tramandate di generazione in generazione. Quindi abbiamo deciso di incanalare alcune di queste competenze nel fare prodotti di terracotta di alta qualità per costruire tetti. È stato il mio primo progetto e a volte mi chiedo cos’è stato a farmi fare questo, se l’innocenza o il coraggio. Penso sia stata l’innocenza”.

Quanto è importante per lei la connessione tra interno ed esterno?
“Anche nel mio corpo c’è porosità. Il mio respiro è sempre connesso con l’aria esterna, in uno scambio continuo fra il corpo, l’acqua e il cibo. Ed è parte dell’ampio habitat in cui viviamo, lo stesso avviene anche per gli animali e le loro case. Gli uomini stanno cercando di fare tutto con il vetro e non permettono più di aprire le finestre. Controllano per quanto tempo e quando le possono aprire: lo chiamano controllo climatico, ma ogni individuo ha il diritto di poter controllare il proprio bisogno climatico. E quindi decidere se aprire o no le finestre. Per questo non sono d’accordo sull’approccio climatico europeo al riscaldamento, bisogna lasciar respirare“.
E poi lei nei suoi progetti fa anche una riflessione molto interessante sul concetto di vuoto…
“Se guardate la struttura delle ossa del nostro corpo è piena di spazi vuoti così anche le pietre, in ogni materiale naturale c’è un vuoto all’interno, un diverso grado di compressione. Devono respirare, così come un mattone è pieno di buchi, ma c’è un respiro dentro, per me è un concetto filosofico trovo delle cose che rigetto e personalmente trovare delle finestre che non si aprono mi indispone. Non mi ha mai convinto. Ho costruito edifici di mattoni forati per trovare questa bella continuità fra esterno e interno per non tagliare di netto le vite umane totalmente dal loro ambiente, è un concetto moderno di ingegneria climatica. Si è visto durante il Covid quanto sia importante la porosità in architettura, in modo che l’aria circoli anche in contesti che hanno poche risorse, in case molto umili”.

Come si traduce, nel concreto, la responsabilità sociale del suo mestiere, l’architetto?
“Non mi sento come una solista che suona. Ha presente il mormorio di uno stormo di uccelli in cielo (e con le mani mima un grande stormo di uccelli in movimento, ndr)? Noi siamo come loro, gli uccelli sono soli e liberi, ma sono nello stesso tempo parte di un gruppo. Quando uno si muove, gli altri seguono. Io mi sento sempre così, è un’illusione credere di essere soli. Nel bene e nel male siamo connessi. L’architettura ha a che fare con l’habitat degli uomini e quindi, in quanto architetta, sono diventata sempre più consapevole che è una professione sociale. Ma non amo l’etichetta di architetta sociale. Per me è importante rendere in architettura i sentimenti delle persone e capire quando vogliono la privacy e quando invece vogliono condividere gli spazi all’interno delle case private o degli edifici pubblici.
La cosa bella dell’architettura è come si disegna in modo lieve la transizione fra come le persone passano fra i vari livelli di cui hanno bisogno, quindi io non so come non essere sociale, non metto in pratica nessuna strategia perché io sono sempre consapevole del mormorio intorno a me. Certo leggo libri, non solo di architettura, che mi influenzano e so che quello che faccio colpisce gli altri e questa è la gioia della vita (rivela con un caldo sorriso, ndr)”.
Quanto è importante per lei il tempo?
“Ho intitolato la mostra retrospettiva al Louisiana Museum in Danimarca ‘Taking Time‘ perché credo che il tempo e la durata della nostra vita siano la nostra risorsa principale. In India tendiamo a posticipare le cose. Trent’anni fa, quando mi sono laureata, ero cosciente di questo problema, ma le persone avevano urgenza, dicevano che non si può perdere tempo per costruire e 30 anni dopo si costruiscono degli orrori in velocità. Quindi è meglio fermarsi, prendersi un po’ di tempo e procedere a piccoli passi. Un po’ come nella storia del coniglio e della tartaruga, con quest’ultima che alla fine vince la gara perché è più lenta e regolare. Per me prendere tempo non vuol dire andare di fretta, ma essere amica del tempo. È l’unico bene che ti viene dato, che tu sia indiano o italiano, ricco o povero, hai comunque 24 ore al giorno. Che tu sia Obama o un contadino non importa, c’è un unico campo in cui sei libero ed è come usi il tuo tempo. Quando ho lasciato Mumbai da piccola non avevo molto. È stata una sfida, ma sapevo di avere il mio tempo, che potevo gioiosamente dedicare a quello che mi piaceva (dice con profondi occhi neri sorridenti, ndr). La vita è breve, bisogna essere consci di ogni minuto che passa e non subirlo passivamente, essere proattivi. E ora, riguardando indietro ai miei 30 anni di attività, quello che mi impressiona è che è stato fatto molto con nient’altro che il mio tempo”.

Che consigli darebbe a un giovane architetto appena laureato?
“Voglio che i miei studenti facciano esperienza sul campo. Esperienza di scale vere, di spazi veri e materiali veri, lavorando a contatto con ingegneri e artigiani. E unendo così le competenze di ingegneria, costruzione, concept e urban design in una sintesi. Amo lavorare in maniera interdisciplinare e tendo a privilegiare la conoscenza intuitiva che deriva dal lavoro manuale, per questo faccio lavorare i miei studenti fuori, perché siano curiosi e apprendano durante il processo. Penso che la cosa più importante che posso suggerire è che la paura non è la strada, non essere impaurito dal prenderti un rischio, non rimanere nella comfort zone: vuoi sicurezza o avventura? Sei giovane, in una fase della tua vita in cui non hai ancora grandi responsabilità, né da un punto di vista del lavoro né da quello della famiglia… Perché esitare, fallo e basta! Ascolta le tue paure, ma vai!”.
La pandemia sta cambiando le nostre città e gli spazi all’interno delle nostre case: come vanno ripensate?
“Con l’arrivo del Covid-19 abbiamo dovuto interrompere tutto quello che stavamo facendo e abbiamo dovuto adattarci. E lo abbiamo fatto molto facilmente. Abbiamo realizzato quali erano i nostri bisogni, che cosa era essenziale e che cosa superfluo, che cosa doveva essere salvato e che cosa sacrificato. È stato un grande insegnamento e la tecnologia ci ha supportato facendoci vivere su piattaforme online. Abbiamo capito cosa ci è utile della tecnologia digitale e quali sono i suoi limiti: può infatti essere oppressiva, ma abbiamo realizzato che tutto il mondo è connesso e possiamo avere una vita diversa. A livello di spazi bisogna trarre vantaggio dalle tecnologie digitali, sfruttare meglio le risorse e il tempo: essere più impegnati e soddisfatti”.
Ha mai visitato Milano, cosa ne pensa?
Sì, ho visitato Milano ma molto velocemente. Ho visto solo la parte più storica. Per me Milano è associata al design, la mia antica passione. È associata alla sua antica tradizione di estetica, ai suoi grandi architetti e alla sua capacità di celebrare il design in ogni campo, anche se è allo stesso tempo molto contemporanea. Sono stata anche a Firenze e Venezia e quello che amo degli italiani è questa sorta di resistenza alla modernità, e un’altra cosa che amo, che avviene anche in India, è l’accoglienza anche senza preavviso, la porta sempre aperta. Appena si potrà voglio tornare per scoprirne anche le nuove trasformazioni urbanistiche”.